
Nel 2009 Sellerio ha raccolto in Altri casi per Petra Delicado tre romanzi di Alicia Giménez-Bartlett pubblicati nei primi anni 2000, con protagonista l’ispettrice di polizia presente in molti altri gialli della scrittrice spagnola: Morti di carta, Serpenti nel Paradiso e Un bastimento carico di riso.
Chi non ha incontrato Petra nei libri di Giménez-Bartlett, ambientati a Barcellona, forse lo ha fatto tra i carruggi di Genova, nella serie televisiva italiana del 2020 diretta da Maria Sole Tognazzi e interpretata da Paola Cortellesi, la cui terza stagione arriva su Sky l’8 ottobre.
Come Sancho Panza per Don Chisciotte, il fido viceispettore Garzón è per Petra compagno di avventure, in questo caso investigative, essendo stata la loro argilla «insufflata di alito poliziesco, il giorno della creazione». Garzón è un uomo all’antica, vedovo, seguace di una moda un po’ datata, con un figlio medico negli Stati Uniti di cui non riesce ad accettare l’omosessualità. Continua a rivolgersi a Petra, suo superiore gerarchico, rigorosamente con il “lei”, che l’ispettrice ricambia, nonostante i molti anni di lavoro insieme abbiano prodotto una sincera amicizia cresciuta per lo più in contesti informali: i due sono soliti discutere i casi in locali come la Jarra de Oro, dove mangiano e bevono di gusto. Come tutte le amicizie sincere, anche quella di Garzón e Petra è vivace e conflittuale: lei è infastidita dal maschilismo congenito di lui e dalle sue incursioni nella propria vita privata sotto forma di domande o consigli non richiesti, sia pur tesi a metterla in guardia e a proteggerla. Del resto la vita privata di Petra è sempre stata parecchio movimentata: si è sposata due volte e due volte ha divorziato. Da allora ha abbracciato una convinta singletudine, che però non significa affatto castità: al contrario, pratica sesso occasionale e disinvolto, del tutto scevro da illusioni sentimentalistiche. Per lei fare l’amore è “una fantastica marachella”, “uno sberleffo alla tristezza e alla morte”, ma non vuole vedere nessuno declinare accanto a sé, né avere un testimone del suo declino: «c’è una certa eleganza nella solitudine, finché la morte non ti separa dal mondo». Petra è bella e ammirata da uomini e donne e tuttavia è consapevole della fugacità dell’apparenza; se almeno invecchiare fosse una trasformazione…e invece no, è «una decadenza dei tessuti, una degenerazione delle cellule». Il personaggio dell’ispettrice è multisfaccettato e affascinante. A volte lei sembra cinica, come quando, nel tentativo di soccorrere sua sorella in piena crisi coniugale, la gela con sentenze affilate e inoppugnabili: «l’amore non è materia analizzabile, lo si sente o non lo si sente», e il marito di Amanda, evidentemente, non lo sente più. «Tutto questo, quando fosse passato qualche anno, sarebbe diventato esperienza di vita, e avrebbe contato a suo favore. Avrei alleviato la sua sofferenza dicendoglielo? No, di sicuro mi avrebbe tirato la teiera in testa»: la consapevolezza di un’inutile lucidità e l’esercizio di una tenace ironia: «entrambe eravamo state educate all’umorismo. Non esiste un’eredità più ricca». Talvolta l’umorismo vira in sarcasmo: «non si ha mai una buona opinione di ciò che si conosce bene». Petra detesta piangere, ama Puškin, beve whisky (ma anche vino e gin), si rilassa con Beethoven, odia l’ipocrisia della commedia sociale, è dotata di un sano realismo che le inibisce l’aspirazione alla felicità. Tuttavia s’immagina «in campagna, in una casetta tranquilla, circondata da cani, gatti e libri, magari con una buona bottiglia di vino di tanto in tanto».
In questi romanzi si apprezza la perizia tecnica nella costruzione dei casi, che si basa su una solida conoscenza del mondo investigativo e di quello criminale. Si tiene altresì in debito conto la nota dipendenza dei commissariati dai giornali e dalla politica, come sappiamo da migliaia di pagine di narrativa di genere, dai film e dalle serie TV: di conseguenza non ci sorprendono le immancabili pressioni che il capo della polizia esercita sui sottoposti. C’è anche la bellezza della scrittura – le similitudini, in particolare, sono sempre divertenti ed efficaci. C’è poi pure tanta Spagna, com’è inevitabile. Barcellona esercita un fascino irresistibile sui madrileni, e Madrid sui barcellonesi; in entrambe le città l’appuntamento per cena è tardi, mai prima delle dieci. A Madrid c’è ancora il locale in cui cenava e si ubriacava Hemingway, ai tempi dei toreri, di Ava Gardner e delle macchine americane; da far venire la nostalgia di un passato mai vissuto. Sopravvive pure, in questi romanzi, un elemento che certo mette in allarme qualcuno: il politicamente scorretto; per quanto mi riguarda, ho nostalgia pure di quello.
Della trama di Morti di carta, come degli altri due romanzi qui citati, non dirò niente. Chi vuole può facilmente trovarla in rete. Mi soffermo invece su aspetti che si ricavano soltanto attraverso l’immersione esperienziale – aggettivo di gran moda – nel testo. Ad esempio, vi si apprende che i sicari italiani «sono i più creativi», e c’era da aspettarselo; ma è con assoluta meraviglia che ricordiamo che nel 2000 le persone – anche se poliziotti – non erano sempre rintracciabili attraverso i cellulari. Inevitabile pure in questo romanzo leggere incongruenze che una pignola come me non può impedirsi di rilevare: a p.103 Petra si accende una sigaretta appena accesa a p.102; a p.111 si avvolge in un asciugamano prima di fare la doccia; a p.144 sbaglia il numero dei morti (a quel punto erano già cinque, non quattro); a p.225 non rileva una contraddizione nella dichiarazione di un indiziato. E poi il movente poco credibile di qualcuno e altre piccole opinabili incertezze nella trama.
In Serpenti nel Paradiso, invece, ha subito suscitato la mia perplessità la circostanza di un uomo trovato a galleggiare a faccia in giù in una piscina, che nessuno aveva provato a recuperare e a rianimare. È credibile? Forse sì, purtroppo, non solo nelle avventure di Petra Delicado. E mi ha colpito una riflessione vera e sconveniente: «è sempre la bellezza di una vittima a suscitare pietà, più della miseria e della sofferenza». Non si può negare, basti pensare alle nostre sensazioni di fronte alle fotografie di certe vittime di crimini o di tragedie. Ma due donne “ultracinquantenni” sono definite “giovanili”, dato che «l’età non inibiva per nulla la loro civetteria». Possibile che solo una ventina di anni fa non si contemplasse la possibilità che una donna “ultracinquantenne” potesse essere ancora giovane (e non giovanile!), sia dal punto di vista biologico, che mentale, che estetico? Non c’erano allora equivalenti di Sharon Stone o di Monica Bellucci oggi? Eppure la scrittura di Giménez-Bartlett tradisce una mortificante percezione collettiva della maturità femminile: un’ultracinquantenne è di per sé una “signora attempata”. Ecco perché Petra, in questo romanzo, avendo superato i quarant’anni, si affretta a soffocare un superstite e malconcio desiderio di maternità. Dopo aver letto circa un terzo di questa storia devo ammettere di aver intuito il/la colpevole, e non sono dotata di particolare acume poliziesco. Mi è però subito parsa sospetta la palese e insolita simpatia di Petra per quel personaggio. In questo romanzo l’ispettrice esplicita una sua vecchia teoria chiamata “sfruttamento integrale delle occasioni”, il cui nucleo primigenio deve essere il noto detto “fare di necessità virtù”. Insomma, lei in circostanze avverse e complesse trova soluzioni creative impiegando elementi di ambiti distinti e amalgamandoli tra loro. Ad esempio sfrutta la sua recente e involontaria frequentazione di un cardinale per ottenere da una gitana fornita di fervore religioso preziose informazioni per un’indagine di Garzón. Oppure fa incontrare tra loro due vedovi che – ahilei! – cercano di stemperare la solitudine coinvolgendola nelle proprie attività ricreative. Tuttavia anche in questo testo si notano sbavature: un’incongruenza temporale, un filo tirato nella trama, a p.430 il riferimento a un’osservazione mai fatta e poi, a p.431, la definizione di “tripartito” per un incontro a due; ma lì si legge pure una riflessione interessante: «niente di ciò che dura è mai banale». Banale no, ma magari cattivo sì.
Di Un bastimento carico di riso ricordo con divertita partecipazione la frase provocatoria con cui Petra fustiga il perbenismo di Garzón: «A me degli onesti padri di famiglia non me ne importa un cavolo. Anzi, penso che se ne facessero fuori qualcuno ogni anno la nostra società andrebbe molto meglio». Era stato ammazzato un senzatetto verso il quale il viceispettore non aveva mostrato pietà, dato che secondo lui non assolveva ad alcuna funzione sociale (diversamente dall'”onesto padre di famiglia” al quale lo aveva incautamente paragonato). In questo romanzo Petra è spesso di malumore, il suo scetticismo è sempre più rigido, astioso, nichilista: «Perché dovrebbe esserci qualcosa che non va? Ho mai avuto bisogno di un buon motivo per essere sgradevole?» Contemplando l’esistenza grama degli emarginati, si spaventa perché sente che non le è estranea; forse le risuona nella mente Publio Terenzio Afro: Homo sum, humani nihil a me alienum puto… Il viceispettore Garzón – o, meglio, l’autrice attraverso il suo personaggio – smaschera una delle bugie più insopportabili e perniciose della società contemporanea: «il lavoro ti deve piacere, l’importante è divertirsi». Questa fandonia viene attualmente propinata anche agli studenti nelle scuole, il che dà loro il diritto di rifiutare fatica e impegno. «Quand’ero giovane io non veniva in mente a nessuno che sgobbare dovesse essere divertente. Lavoravi e non c’erano storie. Se ti piaceva, bene, e se no pochi cazzi», dice Garzón. Matteo Nucci fa dire al grammatico del giovane Platone, Dionisio: “Non credere che sarà facile quel che dovrai imparare. Facile è solo per chi impara male” (in Platone, Una storia d’amore, Feltrinelli 2025). Ecco. Grazie Dionisio e grazie Garzón! È ancora lui a farci riflettere sul fatto che siamo tutti eccessivamente concentrati sui nostri sentimenti personali: «I nostri nonni si rompevano la schiena dall’alba al tramonto per un piatto di minestra, e non pensavano certo ai traumi psicologici». Tuttavia si ritrova anche qui l’odioso pregiudizio misogino: due segretarie, di cui la più giovane è «ben oltre la quarantina» (quindi non ancora cinquantenne?!), vengono definite “signore di una certa età” e “stagionate”…
Anche in questo romanzo emerge qualche imprecisione e lacuna: per esempio nei dialoghi alle pp.566 e 790 a due testimoni non vengono poste domande che invece bruciano sulle labbra di chi legge. Inoltre, curiosamente, a volte si citano gli euro e a volte le pesetas: il libro fu scritto nel 2004 e due anni prima la peseta aveva perso in Spagna il valore legale.
Il personaggio dell’ispettrice è intriso di saggezza filosofica. La fase preliminare delle indagini, in cui si scartano le prime supposizioni, è per lei – chissà quanto consapevolmente – una sorta di vindemiatio prima baconiana: in quella si libera dai pregiudizi, dagli idola che possono offuscare la mente e compromettere il buon esito della ricerca. Questa richiede di tornare spesso indietro e di riesaminare tutto dal principio, secondo la quarta regola del metodo cartesiano, quella della enumerazione e revisione – chissà pure questa quanto avvertita. Quando il suicidio di un notabile viene fatto passare per morte naturale, Petra sbotta: «Ma vi rendete conto? Sono sicura che non veniamo a sapere nemmeno la metà delle cose che succedono nel mondo». Evidentemente si riferisce a quelle che non sono solo puro, accidentale accadere, ma a ciò che è intriso, hegelianamente, di ragione storica. O anche solo di perversa ragione umana. Ed è ancora Hegel, con il suo giustificazionismo, che affiora quando Petra riflette sul pensiero di una ragazza ingenua: «Lei partiva dal presupposto che il mondo è così com’è, mentre io ero arrivata alla stessa conclusione dopo aver pensato per tanto tempo che fosse possibile cambiarlo»; quella di Petra è un’amara resa ragionata, altro che l’ottuso ottimismo degli idealisti, pure inconsapevoli, per i quali ciò che è reale è razionale. Nonostante tu abbia l’impressione di essere ancora in tempo per qualunque cosa, «un bel giorno ti accorgi che la strada che hai imboccato cancella per sempre certe possibilità»: mentre l’ispettrice dialoga con Garzón, è Kierkegaard a parlare, e a ricordarci pure il coraggio della disperazione. Il giudice García Mouriños, cinefilo, ci regala un’altra riflessione di stampo esistenziale: «La vita è più complessa del cinema, Petra, e anche più noiosa. Ha tutto quello che un buon regista tende a eliminare: tempi morti, digressioni, ripetizioni, marce indietro…» Sulla questione Petra ha un’idea precisa: «Di tutto quel che mi è successo nella vita, non ho capito nemmeno la metà. Le cose accadono, e spesso non c’è niente da capire». Quasi tutto nella vita è una giungla, un caos, una corsa al si salvi chi può, «per questo fare progetti mi sembra assurdo, non meno assurdo che non progettare niente». Mi torna l’annotazione di Paul Valery in Tel quel: «Un uomo tirava a sorte tutte le sue decisioni, non gli capitò maggior male che a quelli che riflettono». In fondo la vita non è nulla di «diverso dal lasciarsi continuamente delle cose alle spalle», dice l’ispettrice. Anche se di molte di esse si può fare tranquillamente a meno: dell’aggettivo esperienziale, per esempio.
Cristiana Bullita

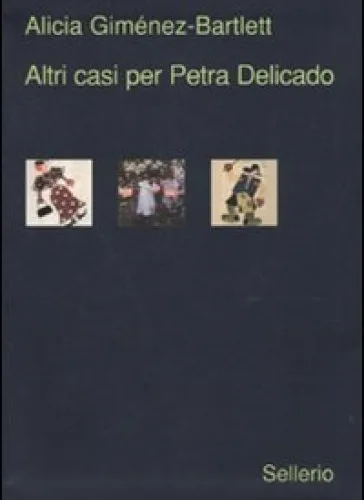
Commenti