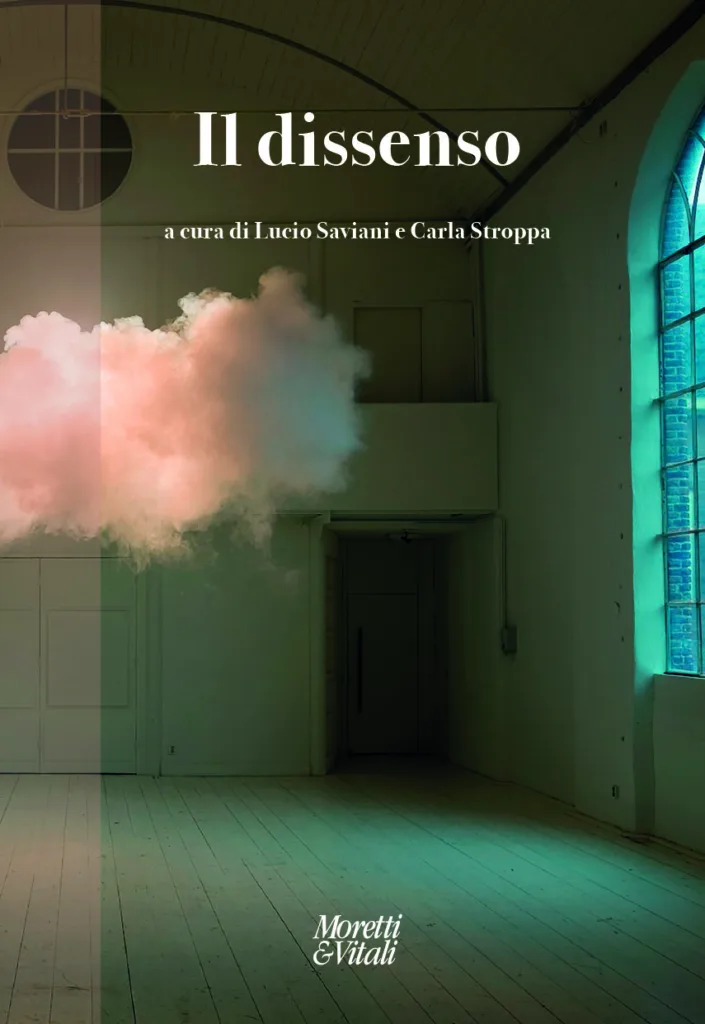
In questo testo Lucio Saviani e Carla Stroppa hanno raccolto, insieme ai propri, piccoli saggi di altri autori e autrici su un tema fondamentale per la filosofia, per la democrazia, per la critica sociale.
Affinché il dissenso non si riduca a semplice negazione o a un rifiuto di maniera, Saviani invoca una pausa finalizzata alla rigenerazione della riflessione, uno stacco dalle attività, quasi un fermo biologico che mantenga la fertilità del pensiero e della società. “Mettersi a maggese”, dice l’autore citando Masud Khan, è indispensabile al processo dinamico di trasformazione che si vorrebbe imprimere. Tuttavia, nella contemporaneità, il dissenso è spesso depotenziato e confinato nel perimetro di una “tolleranza repressiva” entro il quale “si può dire tutto purché non si dica qualcosa che non si possa dire”. Nulla di realmente intollerabile e dirompente ascoltiamo su certi palchi estivi che promettono filosofia, o nei dibattiti televisivi, in cui il dissenso è finto e la discussione sorda e caricaturale. La filosofia è dis-sociazione, ci ricorda Saviani citando Fink, e discorrere implica, etimologicamente, un “correre di qua e di là”. Pensare significa domandare e rispondere, affermare e negare: il dissenso è il senso stesso della filosofia.
Il tema del dissenso è trattato da Carla Stroppa come resistenza creativa del sé all’omologazione e al conformismo di idee e comportamenti imposti dalla società. Il dissenso è visto come una protesta dell’inconscio contro la pressione dello spirito del tempo, che detta regole di performance, estroversione e competenza tecnologica. L’autrice sottolinea l’importanza di sganciarsi dal contingente e aprire lo sguardo sugli archetipi che fondano i comportamenti, per comprendere meglio la psiche umana e i rapporti tra i generi.
Nicola Magliulo tratta il tema del dissenso come fondamentale per la democrazia e la pluralità, in contrapposizione alle tendenze autoritarie e totalitarie che cercano di ridurre la diversità e reprimere le voci dissenzienti. L’autore identifica tre direzioni in cui il dissenso è minacciato: la globalizzazione capitalistica e il pensiero unico, gli imperi autocratici e la riduzione della democrazia, e la civiltà della tecnica che appiattisce l’uomo su una sola dimensione.
Per Graziano Valent il tema del dissenso è nodale per comprendere la follia e il suo rapporto con la realtà. Tenendo accese nella mente e nel cuore la psichiatria di Basaglia e la filosofia di Italo Valent, l’autore sostiene che la follia non è una malattia da curare, ma un diverso sentire che esprime dissenso rispetto alla lettura ordinaria del mondo. La psichiatria tradizionale cerca di ricondurre la follia alla cosiddetta realtà, mentre Valent propone un approccio dialettico che consenta di possibilizzare la propria visione e di confrontarsi con il folle in un’ottica di servizio e di trasformazione reciproca. Il delirio del folle, per Valent, è un modo problematico della ragione.
Maria Rosa Tinti abbraccia la medesima prospettiva: il folle dice “no” alla civiltà, alla ragionevolezza e alle convenzioni sociali; il suo rifiuto è espressione di libertà e autodeterminazione. Per l’autrice la psichiatria tradizionale ha cercato di reprimere e tacitare la follia, negando il suo valore antropologico e il dissenso del folle. Al contrario, la relazione terapeutica dovrebbe essere basata sul conflitto e sul riconoscimento del dissenso, piuttosto che sulla ricerca di un’armonia artificiale.
Růžena Hálová dimostra come il tema del dissenso rappresenti un’efficace chiave di lettura della storia del popolo ceco, dal movimento hussita del XV sec. fino alle rivolte contro il regime comunista del XX sec. In Boemia il dissenso ha significato l’espressione di un pensiero ribelle in forme diverse, dall’eresia all’avanguardia artistica, fino all’opposizione politica. I personaggi citati, come Jan Hus e Václav Havel, sono esempi di dissidenti che, in tempi diversi, hanno sfidato il potere costituito e hanno lottato per la libertà. Il saggio evidenzia anche il ruolo decisivo della lingua e della cultura nella formazione dell’identità nazionale di un popolo.
Domenico Zampaglione tratta il tema del dissenso come critica alle istituzioni religiose e politiche dominanti. L’eresia è la scelta consapevole di opporsi alle dottrine ufficiali della Chiesa cattolica. Gli esempi storici di eresie – l’arianesimo, il manicheismo, il catarismo, il pelagianesimo –, e poi le riforme e gli scismi, mostrano come il dissenso religioso possa esprimere contenuti diversi: critica alla gerarchia ecclesiastica, ricerca di semplicità e purezza spirituale, contestazione all’autorità della Chiesa, alle sue tesi teologiche e prassi dottrinali. La repressione delle eresie da parte della Chiesa cattolica avviene con l’imprescindibile contributo dell’autorità civile; la messa in discussione di un qualunque potere costituito mina infatti tutti gli altri, il che contribuisce a spiegare il tenace blocco storico di trono e altare. Il dissenso religioso è importante nella storia della civiltà occidentale, anche perché ha contribuito a preparare il terreno per la modernità e la scienza.
Roberto Cossu tratta il tema del dissenso attraverso la filosofia di Pavel Florenskij, che si oppone alla modernità e al pensiero dominante dell’epoca sovietica. Florenskij rivendica l’importanza della spiritualità, della simbolicità e della trascendenza nell’arte e nella vita, in contrapposizione alla prospettiva lineare e materialistica della modernità. Il suo pensiero è caratterizzato da un forte idealismo platonico e da una concezione dell’arte come mezzo per accedere al mondo spirituale e alle idee eterne. La critica alla contemporaneità e al potere sovietico si esplicita anche nella difesa della tradizione ortodossa e della cultura popolare, e nella rivendicazione dell’importanza dell’eterno e del divino nella vita umana.
Margherita Platania tratta della “nuova storiografia israeliana”, un gruppo di studiosi israeliani che mette in discussione la narrazione ufficiale della storia di Israele e la costruzione della sua identità nazionale. Benny Morris, Avi Shlaim, Ilan Pappé, Zeev Sternhell e altri, attraverso l’analisi dei documenti d’archivio, demoliscono i miti fondativi dell’identità israeliana e rivelano la violenza e la discriminazione esercitate contro i palestinesi. Il dissenso di questi storici è visto in genere dalla società israeliana come una minaccia al senso di appartenenza alla nazione; essi vengono attaccati e accusati di antisionismo e antisemitismo. Per Israele, il loro è un odioso tentativo di rivedere la storia al fine di riconoscere i diritti dei palestinesi, mettendo in discussione la narrazione ufficiale e la politica israeliane.
Con una prosa poetica d’indubbia suggestione, Antonio Cipriani riflette sulla “società del controllo”, in cui il potere dominante cerca di annullare ogni ribellione. L’autore propone una forma di dissenso passivo, basata sul “non fare” e sull’indifferenza al successo e al potere. Il dissenso deve essere un atto di resistenza individuale e collettiva, volto a preservare la propria libertà e autenticità in un mondo che sembra aver perso ogni profondità e significato. L’autore suggerisce di adottare piccole forme di sabotaggio e di coltivare comunità che si oppongano alla logica dominante. Sollecita tuttavia il dissenso del lettore quando sostiene: “Di tutto ciò che ho scritto se ne può fare tranquillamente a meno”: la sua riflessione ispirata ci appare invece tanto bella quanto necessaria.
Recensione di Cristiana Bullita


Elogio del dissenso a tutto tondo, mi par di capire, specie quando il sollecito è nella frase “Di tutto ciò che ho scritto se ne può fare tranquillamente a meno” per coerenza e accettazione della critica altrui, in senso plurale e democratico. Grazie per questo nuova interessante recensione.